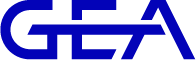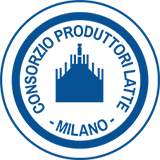Sergio Visini
Grezzana, Verona – ITALIA

“La suinicoltura italiana ha bisogno di investimenti, programmazione produttiva, specializzazione e di una rivoluzione culturale che abbracci tanto la produzione quanto il marketing. Senza questi elementi, inutile sperare nella competitività e nel futuro del settore”.
Ha le idee molto chiare e non ci gira troppo intorno Sergio Visini, allevatore bresciano che gestisce due porcilaie tra Grezzana (Verona) e Pegognaga (Mantova), in collaborazione con Bompieri. Circa 800 scrofe sono di fatto il serbatoio per il sito 2 nel Mantovano, dove è stato costruito un allevamento completamente nuovo con svezzamento e ingrasso. In totale sono poco più di 19.000 suini all’anno.
Quali sono i tratti distintivi dell’impianto?
“Lo svezzamento è su paglia, mentre l’ingrasso è con pavimento pieno e palchetto parzialmente fessurato. Utilizziamo solo la ventilazione naturale in tutti i padiglioni monofalda su cui abbiamo installato due impianti di fotovoltaico da 1 megawatt (uno in autoconsumo). Abbiamo anche un impianto di biogas per valorizzare i reflui, riutilizzare il calore e ridurre così l’impatto ambientale. Inoltre, impieghiamo dei microrganismi per abbattere gli odori”.
Che tipo di animale allevate?
“Dal 2017 abbiamo scelto di aderire alla filiera antibiotic free e portiamo gli animali a 175 chili”.
A chi vendete?
“A Opas per il circuito del Prosciutto di San Daniele, marchio Principe, con la quale Opas ha avviato una collaborazione per valorizzare anche il resto della carcassa per carne fresca o insaccati, dal momento che è antibiotic free”.
Vi siete orientati su una produzione molto richiesta e specifica. Qual è la remunerazione in più per l’allevatore?
“Viene riconosciuto un premio in più per capo. Il risultato, di fatto, è legato alle cosce, ma, come dicevo, stiamo sperimentando per estendere i benefit anche al resto dell’animale. Abbiamo adottato una logica produttiva di tipo industriale, da intendersi in chiave di organizzazione, efficienza, tracciabilità, servizio tecnico, ma anche genetica e strutture. Nulla è lasciato all’approssimazione, data la peculiarità di questo mercato”.
Appunto. Quello suinicolo è un mercato che sta scontando una marcata volatilità. Perché, secondo lei?
La volatilità è legata all’assenza di programmazione
“La volatilità è legata alla totale assenza di programmazione. Senza una pianificazione produttiva condivisa e una progettualità dall’allevamento al prodotto finito non si può pretendere di governare il mercato”.
L’Italia ha un tasso di autoapprovvigionamento che non arriva al 65%, secondo le elaborazioni di Teseo by Clal. Ritiene sia un elemento penalizzante per la programmazione suinicola?
“Il dato dell’autosufficienza, in verità, mi interessa relativamente. Non facciamo carne di macelleria e non abbiamo mai pensato di farla. Invece, credo che sia giunto il momento di ragionare per produrre carne di alta qualità. È mai possibile che nei grandi ristoranti italiani propongano carne suina spagnola e non italiana? E non credo sia colpa della ristorazione, se noi non ci siamo mai posti l’obiettivo di proporla”.
Fra gennaio e maggio 2020, secondo le elaborazioni di Teseo by Clal, abbiamo esportato meno di 150mila tonnellate di carne e preparati. La Francia 313.500 tonnellate, la Polonia 329.000, per non parlare di Olanda (651.000 tonnellate), Danimarca (605.000), Spagna (1.100.000 tonnellate) o Germania, leader a livello europeo con un export di oltre 1.400.000 tonnellate. Quanto pesa, secondo lei, questo gap e come ridare competitività alle imprese?
Investire sull’export ed eliminare le inefficienze all’interno della filiera
“Pesa moltissimo. Ma non abbiamo mai investito sull’export e mai, come dicevo prima, puntato sulla carne fresca di alta qualità. Ha iniziato da qualche tempo Opas con il marchio Eat Pink. Credo che ci siano spazi, perché il prodotto italiano ha qualità superiori, sia in termini organolettici che qualitativi. Avendo però un suino pesante, va trattato di conseguenza, magari con una frollatura idonea. Dovremmo, quindi, investire sulle celle di frollatura. Allo stesso tempo, dovremmo investire per eliminare le inefficienze all’interno della filiera.
La Spagna può essere vista come un modello?
“Parto da un dato. Trenta anni fa la Spagna aveva circa lo stesso numero di maiali dell’Italia. Oggi noi siamo sugli stessi volumi, mentre la Spagna alleva più di 30 milioni di capi. Hanno saputo valorizzare la propria filiera, attraverso leve di marketing vincenti già 20 anni fa, quando puntavano moltissimo sull’export. Anche loro avranno avuto i problemi ambientali, la difficoltà nei rapporti con i cittadini, una classe politica con cui confrontarsi, eppure hanno saputo sfruttare un concetto di cultura alimentare che è molto simile alla nostra, ma che noi italiani non abbiamo saputo o voluto valorizzare. Dovremmo imparare dal mondo del vino, che ha saputo costruirsi una identità territoriale molto forte”.
Come mai l’Italia è rimasta ingessata?
“Non abbiamo costruito un progetto. E i macellatori hanno fatto da tappo a qualsiasi progettualità. Di più, non hanno saputo valorizzare anche i nostri gioielli, come i prosciutti di Parma e San Daniele. Ma le colpe, probabilmente, sono di tutti. Non siamo stati in grado nemmeno di far funzionare la Cun”.
Quali sono, secondo lei, i limiti della Cun?
“È limitativo pensare a un confronto fra due componenti della filiera senza tutti gli altri. Si confrontano allevatori e macellatori. E gli altri attori?”.
Chi vorrebbe inserire?
“I prezzi della materia prima, secondo me, devono essere in funzione del prodotto finito. Se vogliamo dire che la Cun deve definire un prezzo minimo garantito per chi fa un prodotto base, può eventualmente anche andare bene. Ma se ci orientiamo, come è il modello Made in Italy, su filiere, prodotti dop e di alta gamma, allora bisogna ripensare il sistema di formazione del prezzo. Chi mi fa investire nelle aziende, nel benessere animale, se non c’è remunerazione?”.
I prosciutti Dop sono ancora strategici per la filiera italiana? Come ne rilancerebbe i consumi e i prezzi?
“Sì, sono ancora strategici, ma non dobbiamo dimenticare che, se vogliamo essere protagonisti su un mercato di alta gamma, dobbiamo garantire credibilità e immagine, qualità del prodotto e, soprattutto, in maniera costante. Se non distinguo un prosciutto Dop da uno generico, perché dovrei comprarlo?”.
Dove migliorare?
Serve una standardizzazione di prodotto verso l’alto
“Serve standardizzazione di prodotto verso l’alto, partendo da materia prima di alta qualità. Non possiamo pensare che ogni allevamento abbia variazioni qualitative anche marcate. Un altro punto chiave è il packaging: siamo rimasti indietro e non ci differenziamo. Questo perché ci manca la cultura del prodotto di alta gamma. Guardiamo la Spagna, ancora una volta, e il prosciutto Pata Negra: è un brand a tutti gli effetti, raro e costoso, ma curato anche nei dettagli del packaging, perché l’immagine di un prodotto di alta gamma non è banale”.