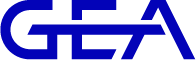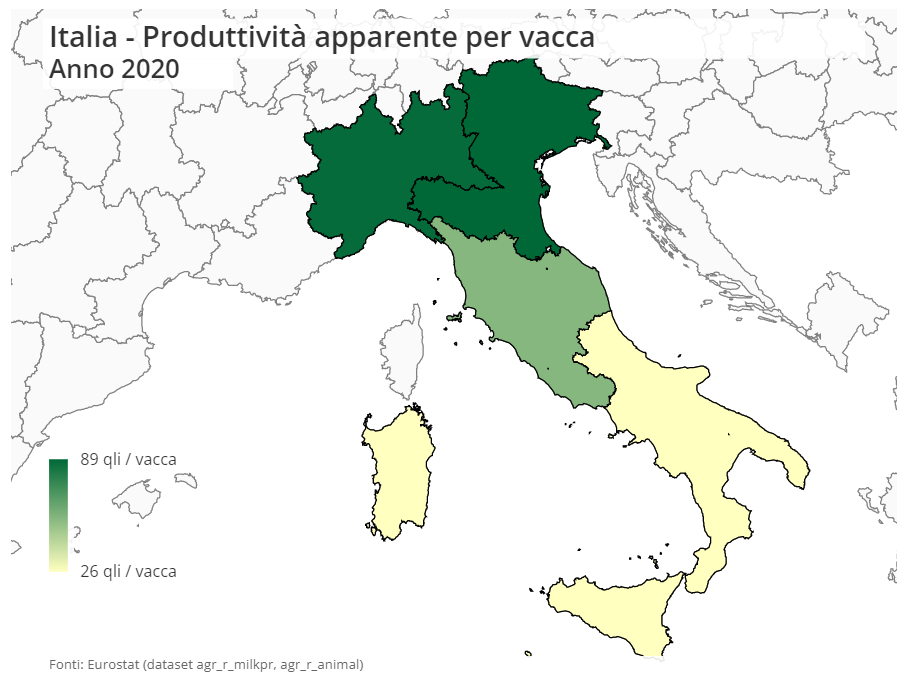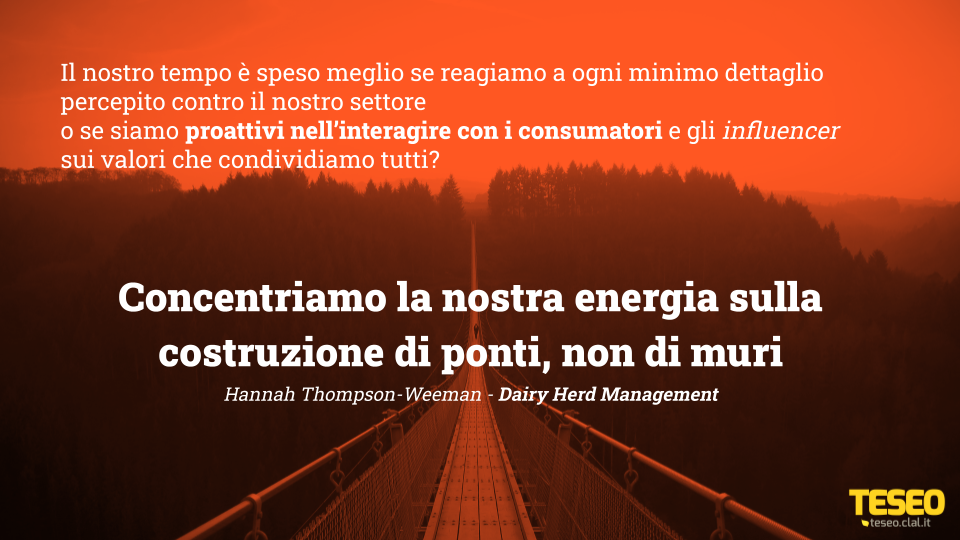Pietro Pizzagalli, 44 anni, veterinario, per dieci anni ha seguito lo sviluppo della filiera all’interno del gruppo Fumagalli, l’azienda di famiglia. Altri dieci anni, circa, come responsabile della produzione e, da un anno e mezzo, direttore generale dopo il compimento del passaggio generazionale delle aziende del gruppo.
La filiera che rifornisce l’azienda si ispira ai concetti del benessere animale, dell’uso responsabile del farmaco. Nel 2020 Pietro Pizzagalli è stato insignito del premio “Allevatore dell’anno” della rivista Informatore Zootecnico, “per aver messo in pratica su vasta scala i più severi standard previsti per il benessere animale. Un premio – si legge nelle motivazioni – per la moderna concezione dei nostri allevamenti suinicoli, sempre più sostenibili, efficienti, animal friendly”. Questo spiega la grande attenzione che mostra nei confronti di sanità, salubrità e benessere come chiave per ottenere prodotti di qualità, apprezzati dai consumatori.
Direttore Pizzagalli, come evolverà il 2024 per la suinicoltura italiana?
“Ritengo che il calo del numero dei suini disponibili legato a problematiche sanitarie e alla chiusura di realtà non competitive porti il prezzo del suino vivo a rimanere alto. Se combiniamo il prezzo del vivo e il calo del costo alimentare, per gli allevatori dovrebbe essere un anno positivo. Tale dinamica rafforzerà il processo di integrazione”.
In che senso?
“Nel senso che oggi, il 50% dei maiali è prodotto prevalentemente da grandi gruppi. Nel momento in cui il prezzo del suino sul mercato resta elevato e il costo di produzione diminuisce, i grandi gruppi riescono a conquistare nuovi spazi, coinvolgendo quegli allevatori singoli che negli anni hanno investito poco e, in questa fase in cui fra benessere animale, biosicurezza, urgenza di contrasto alla Peste suina africana serve investire, si dirigono verso i grandi gruppi.
Ritengo che la suinicoltura debba compiere un salto in avanti
Ritengo che in questa fase la suinicoltura debba compiere un salto in avanti, migliorando come dicevo sanità e benessere animale, riducendo l’utilizzo degli antibiotici, abbassando il tasso di mortalità negli allevamenti. Se pensiamo che oggi mancano circa il 20% dei suini nel percorso fra tatuati e macellati per le Dop, al netto del calo legato alle genetiche, significa che la percentuale di mortalità è comunque elevata.
Bisogna migliorare il dialogo all’interno della filiera. Non si può pensare solo a produrre tonnellate di carne e basta. In questa fase di scarsa produzione in Italia e in Europa, poi, si aggiunge un altro problema”.
Quale?
“Chi macella e non ha un bacino sicuro di approvvigionamento di suini perché non si è preoccupato della prima fase della produzione, oggi ha qualche grattacapo. Noi come Fumagalli siamo l’unica azienda rimasta col processo di macellazione interno, ma il resto dei macelli italiani deve fronteggiare una diminuzione del numero di capi allevati e fatica a coprire i ritmi canonici di macellazione. Il continuo aumentare dei costi, insieme alla riduzione dei numeri, può essere un elemento di preoccupazione per il futuro”.
Come vede le grandi Dop della salumeria?
“La mia visione è quella di chi vive il campo partendo dall’allevamento. Credo che si sarebbe potuto fare un lavoro migliore in termini di capitolati del Prosciutto di Parma e San Daniele, valorizzando maggiormente la qualità, definendo meglio i parametri della mezzena, ragionando sulle genetiche, senza affidarci alla burocrazia come elemento regolatore. Avrebbero dovuto sedersi i produttori e la filiera in maniera trasparente, affrontando tutti i temi, così da avanzare richieste precise alla politica. Si è fatto il contrario, ci si è affidati alla politica, procedendo per mediazioni. E tutto perché non ci si parla”.
Abbiamo divagato rispetto al futuro del settore nel 2024. Stava parlando di criticità.
“Sì. Nel 2024 direi attenzione alla Psa, perché nel momento in cui si estende in zone ad alta densità suinicola mette fortemente in crisi la sopravvivenza delle aziende sia per il valore del prodotto messo sul mercato sia per i problemi produttivi generati dalle restrizioni nella gestione delle aree infette”.
Come giudica la gestione della Psa, presente in Italia da ormai due anni?
“Purtroppo i problemi non gestiti o mal gestiti diventano un’emergenza e nella fase emergenziale poi è difficile tenere una linea decisionale in grado di soddisfare le esigenze di una filiera produttiva.
Un anno fa parlavamo di abbattimento di cinghiali, oggi se ne parla poco, perché dobbiamo parlare di come gestire gli allevamenti nelle aree infette. Quello che dallo scorso settembre si verifica nella zona di Pavia e oggi a Piacenza può essere una seria minaccia alla sopravvivenza delle aziende suinicole.
Rispetto ai tempi di intervento e ai tempi decisionali di cui avremmo bisogno siamo costantemente in ritardo”.
Ci saranno maggiori spazi di export nel corso dell’anno, dopo un 2023 che nei primi nove mesi dell’anno ha segnato un rallentamento delle vendite fuori Italia?
“La Psa da sola ha chiuso completamente dei mercati che difficilmente riapriremo, se non avremo buona capacità di negoziazione. Inoltre, credo che il fenomeno inflattivo abbia spinto il consumatore estero a privilegiare i prodotti di autoproduzione interna rispetto a quelli importati. Non tutti i Paesi esteri hanno performance uguali, ma credo che queste due riflessioni possano essere generalizzate”.
Molto spesso gli allevamenti sono visti negativamente dall’opinione pubblica per diversi fattori (benessere animale, emissioni). Come si potrebbe comunicare una visione diversa del comparto?
L’unica soluzione è lavorare bene
“L’unica soluzione è lavorare bene e non è uno slogan. Bisogna far sì che la fase di allevamento sia più attenta alle tematiche che oggi il consumatore ritiene essere una condizione sine qua non per poter considerare il consumo della carne come sostenibile e rispettoso. Detto questo, le tematiche sono le stesse, ovvero il benessere animale, la riduzione e controllo dell’uso dell’antibiotico, i sistemi di allevamento. Sono convinto che tutto questo si possa fare, ma è necessario che la filiera si confronti su queste tematiche, lasciando da parte la contrattazione commerciale”.
Ritiene che sia utile un Tavolo di filiera oppure, visti i precedenti che non hanno mai portato risultati concreti, non se ne sente l’esigenza?
“Ritengo sia essenziale, se composto da operatori che vivono il settore, quindi gli stessi produttori. Quello che è successo negli ultimi tre anni ci pone l’obbligo di fare riflessioni non più a compartimenti stagni, ma di filiera”.
Il futuro della suinicoltura italiana passa inevitabilmente dalla salumeria di qualità?
“Credo proprio di sì. Bisogna capire cosa vuol dire qualità: la difesa del prodotto italiano derivante dal suino pesante non si può pensare di farlo con la burocrazia e la politica, ma lo si deve fare con l’attenzione alla qualità del prodotto finito. Nel momento in cui si perde di vista questo aspetto, il consumatore si rivolgerà a prodotti a minor costo”.
Con prezzi di mercato così alti per le cosce (ormai da diversi mesi), come pensa si possano incentivare i consumi di prosciutto crudo Dop?
Il consumatore deve spendere di più, ma attenzione alla distribuzione del valore
“I prezzi alti sono una conseguenza di domanda e offerta. Due riflessioni, però, in merito. La prima: la difesa del prezzo alto si può fare, se la filiera è in grado di garantire la qualità del prodotto e se i consorzi mettono in atto una strategia di comunicazione dei valori del prodotto.
La seconda riflessione: il consumatore deve spendere di più, però attenzione a come è distribuito il valore e il margine lungo tutta la filiera del prodotto. Su questo aspetto bisogna lavorare, perché negli anni l’equilibrio si è spostato verso la parte finale della catena, impoverendo chi fa il prodotto. Un riequilibrio sarebbe la garanzia sia per la qualità dei prodotti che per la tutela dei consumatori”.