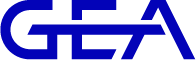Carlo Franciosi
Ossago Lodigiano, Lodi, Lombardia – Italia
Capi allevati: 2.000
Destinazione del Latte: latte alimentare
Carlo Franciosi, titolare della società agricola Franciosi Massimo e Carlo s.s. di Ossago Lodigiano, è un allevatore con circa 2.000 capi in stalla, 460 ettari coltivati, 17 fra dipendenti e collaboratori. Conferisce il latte a Granlatte e ha fatto della sostenibilità la propria missione. CLAL lo ha intervistato, partendo da un dibattito aperto in Europa sulla sostenibilità ambientale, sul ruolo della zootecnia e sulla dimensione ideale della stalla (se esiste). Il ruolo della zootecnia legato al rapporto con l’ambiente ha spinto alcuni Stati, dalla Germania alla Danimarca, dai Paesi Bassi all’Irlanda, a invitare gli allevatori a ripensare il proprio approccio, magari riducendo il numero di capi o implementando soluzioni di economia circolare.
Franciosi, esiste una dimensione ideale per la stalla?
Non esiste una dimensione ideale per la stalla
“No, non esiste una dimensione ideale per la stalla. Ogni realtà deve essere parametrata al terreno che ciascun allevatore coltiva. Noi, ad esempio, abbiamo una stalla con 2.000 bovine e circa 460 ettari di terreni. E tutta la superficie coltivata serve per l’alimentazione degli animali e per la valorizzazione delle deiezioni. Oltre all’azienda principale, distribuiamo digestato su un’altra azienda di circa 50 ettari, che è coltivata da un cugino, nel rispetto dei vincoli di spandimento fra aree vulnerabili ai nitrati e aree non vulnerabili. I vincoli ambientali rappresentano un parametro da rispettare”.
Le norme ambientali invitano ad essere molto attenti in tema di digestato. Come lo gestite?
“Procediamo con l’interramento del digestato. Tutti i reflui passano dal digestore anaerobico, che serve per la produzione di biogas da 300 kw. È alimentato esclusivamente con liquame e letame. Il digestato che rimane dal processo di produzione di biogas viene interrato, grazie a un sistema di distribuzione interrato, che raggiunge quasi tutta la superficie aziendale. E dove non riusciamo ad arrivare, utilizziamo una botte con ramponi per interramento”.
Una delle grandi emergenze territoriali riguarda i cambiamenti climatici. Come è possibile, secondo lei, contrastarli?
“Dei cambiamenti climatici si incolpa sempre e volentieri l’allevamento intensivo. Mi lasci aggiungere: anche ingiustamente si incolpa la zootecnia. Come azienda sono stato oggetto di ricerca relativamente ai valori delle emissioni in atmosfera e la raccolta e l’elaborazione dei dati è stata fatta dal professor Giacomo Pirlo del Crea di Lodi.
Cosa è emerso?
“In base ai calcoli, e con il contributo del biogas, si immettono molti meno inquinanti in atmosfera e quindi con il fatto che le bovine da latte sono delle divoratrici di alimenti che catturano CO₂, ne risulta un bilancio positivo in quanto si cattura più CO₂ di quella che si immette in atmosfera.
Mi sembra, quindi, ragionevole affermare che non è l’allevamento intensivo che provoca il surriscaldamento dell’atmosfera, ma sono altri fattori: industria, abitazioni, automobili, autotrasporti pesanti, aerei, trattori. Ogni volta che si muovono, emettono calore e inquinanti in atmosfera. Dobbiamo fare in modo di creare energia, senza produrre calore. Bisognerebbe puntare sull’elettrico, anche se resta il nodo del fabbisogno energetico elevato”.
Il nucleare potrebbe essere d’aiuto?
“Sì. Penso che il nucleare sia un male necessario. Perché dobbiamo creare energia. Abbiamo appena installato un impianto fotovoltaico da 350 kw, mentre il biogas è già in funzione da 5 anni. Opera grazie ai reflui zootecnici e ci permette di fornire energia potenzialmente per mille famiglie. Significa che ogni vacca produce energia per una famiglia, abbattendo l’uso di energie fossili. Ma c’è ancora chi è convinto che le vacche inquinino”.
La prossima frontiera per l’agricoltura sarà il sequestro di carbonio.
“Sì, sono in attesa di maggiori notizie per capire come certificarmi e proseguire il percorso virtuoso di economia circolare. Dobbiamo come allevatori respingere le accuse infondate di essere degli inquinatori, ma contemporaneamente dobbiamo fare in modo di proseguire nell’essere virtuosi e cercare di migliorare. Le dirò di più: sono in attesa che venga commercializzato un trattore elettrico efficiente; in quel caso amplierei le superfici di fotovoltaico sui tetti per adottare trattrici elettriche”.
Cambio argomento. Qual è, in base alla sua esperienza, il vantaggio della cooperazione?
Sono molto soddisfatto del mondo cooperativo
“È grande e ha più risvolti interessanti. Innanzitutto, grazie al sistema cooperativo sei protetto. Questo significa che il tuo latte è sempre venduto, non rischi, come è capitato a qualche allevatore in alcune fasi critiche, ad esempio dopo la fine del regime delle quote latte, di non vederti ritirato il latte. Certo, devi produrre rispettando benessere animale, qualità, rispettare determinati parametri, ma tutto questo significa produrre nel modo corretto. Personalmente sono molto soddisfatto del mondo cooperativo”.
La riforma della Pac vieta, di fatto, la monocoltura mais su mais. Questo la preoccupa?
“No, non mi preoccupa, è giusto coltivare rispettando la rotazione. Personalmente cerco di impostare la rotazione alternando erba medica, erbai autunno-vernini e mais. È il prodotto che mi serve per alimentare le bovine”.
Come immagina il settore fra dieci anni?
Professionalità, organizzazione, sostenibilità: le caratteristiche delle stalle del futuro
“Prevedo che ci saranno meno aziende di quelle che ci sono oggi. Rimarranno quelle che si saranno attrezzate per il futuro. L’automazione credo che sarà una scelta obbligata, per carenza di manodopera, se poi nelle stalle verranno installati robot di mungitura o impianti a giostra dipenderà dalle dimensioni e dalle libere scelte imprenditoriali di ciascun allevatore, ma penso che prima o poi si dovrà decidere come fronteggiare la mancanza di collaboratori.
Un altro tratto che ritengo distinguerà le stalle nei prossimi dieci anni sarà la professionalità, perché quello dell’allevatore è un mestiere che richiede attenzione e precisioni, tanto nelle operazioni in campagna quanto in stalla e nella conservazione dei prodotti agricoli, un aspetto quest’ultimo che in futuro farà la differenza.
Sul fronte prezzo non riesco a indicare un futuro con sicurezza, ma non penso che fra dieci anni avremo prezzi del latte alla stalla molti diversi da quelli attuali. Forse qualche centesimo in più, forse in meno, ma senza grandi variazioni. Le stalle che sopravviveranno saranno quelle in grado di esprimere organizzazione, professionalità e sostenibilità”.
Lei quali investimenti suggerirebbe a un collega allevatore?
“Suggerirei di investire nell’ammodernamento delle strutture, nella computerizzazione e digitalizzazione delle attrezzature, nel cercare di essere sempre più evoluti in tema di benessere animale, spazi adeguati, strumenti di monitoraggio e analisi, perché il futuro sarà quello”.